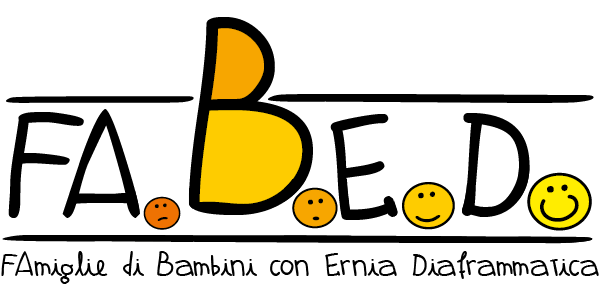Una Madre racconta
Questo testo che segue è stato fornito dalla Dottoressa Aite che potete contattare nella pagina “I nostri Esperti”, collabora con questo sito per gli aspetti di carattere psicologico.
La diagnosi prenatale di anomalia congenita:
“Una madre racconta”
La diagnosi prenatale di una grave malformazione congenita si configura per le coppie e in particolare per le madri come un momento di grave crisi. Trovano conferma le fantasie di generare un figlio non sano e i timori di inadeguatezza e di fallimento, riportati dagli autori come normali in gravidanza. La madre è obbligata a confrontarsi con la perdita del bambino atteso e immaginato fino ad allora e con la ferita narcisistica che ne deriva.
Nella scarsa letteratura esistente su tale problematica, rilevante ci è parso il contributo di Drotar. Secondo l’autore, il processo di adattamento che i genitori affrontano a partire dalla diagnosi va dallo shock iniziale fino alla riorganizzazione, passando attraverso la negazione, la rabbia, il dolore e l’adattamento alla realtà.
Attraverso la “storia” personale narrata da una madre ci proponiamo di osservare come si caratterizza in questa donna il processo di adattamento alla diagnosi prenatale di anomalia congenita.
Situazione clinica
La coppia in attesa del primo figlio giunse alla nostra osservazione alla 23° settimana di gravidanza da un’altra regione d’Italia su invio del ginecologo curante, che una settimana prima aveva diagnosticato nel feto un’ernia diaframmatica sinistra.
A partire dalla comunicazione della diagnosi la mamma è stata seguita dall’équipe lungo tutta la gravidanza fino all’intervento chirurgico e alla dimissione dall’ospedale.
1. Durante la gravidanza
Al termine dell’ecografia che confermava la diagnosi già ricevuta, questi sono i vissuti riportati dalla madre: “L’unica cosa che ricordavo, dopo il primo colloquio con il chirurgo neonatale, era che mio figlio aveva solo il 60% di possibilità di sopravvivere. Le altre parole del dottore le ascoltai, ma le incamerai solo in parte, era come se non ci potessi riflettere. Il terrore mi faceva abbandonare il pensiero e non fui capace di fare nemmeno una domanda. Perché Dio mi metteva di fronte a un’esperienza del genere? Ero arrabbiata. Che avevamo fatto io e mio marito per vedere distrutto il nostro desiderio di mettere al mondo un figlio? Anche se i medici mi avevano detto che non dipendeva da me, mi sentivo in colpa, lui era dentro di me, ero io che lo stavo facendo crescere ed ero quindi io che l’avevo fatto malato. Visto che l’assenza di una risposta al perché mio figlio stesse male, a tratti diventava intollerabile, preferivo pensare che non era vero, che si erano sbagliati. Mi ripetevo che alla nascita mi avrebbero detto che stava bene. Ho comprato poche cose per mio figlio in gravidanza e quando mi capitava di riordinarle pensavo che forse non le avrebbe mai indossate, questa era la mia paura costante. Si, in alcuni momenti pensavo alla morte di mio figlio e, come dire, non c’era la paura ma ero io stessa la paura” .
2. Dopo la nascita
Alla nascita, come previsto e concordato con i genitori, il bambino è stato trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù e, a motivo delle sue gravi condizioni respiratorie, è stato intubato e sedato per prepararlo all’intervento chirurgico.
Ecco le osservazioni della madre quando descrive il suo primo incontro con il figlio in terapia intensiva, a cinque giorni dal parto: “Quando mi avvicinai a lui, il mio primo pensiero fu: questo non è mio figlio, avevo solo voglia di scappare. Non avevo il coraggio di toccarlo, temevo di potergli fare del male. Anche nei giorni seguenti, quando stavo accanto all’incubatrice, mi dicevo: che ci faccio io qui? ma questo è veramente mio figlio? In quei giorni la paura era costante e l’interrogativo sempre presente, che mi occupava la testa, era: vivrà?, respirerà mai da solo? Andavo da lui ogni giorno ma non lo sentivo ancora mio, c’era ancora distanza tra noi. Mi dicevo: forse sono diventata pazza, come è possibile che non lo sento ancora mio, è una cosa così innaturale!”
Quando, a un mese di vita, il bambino viene finalmente estubato e trasferito in chirurgia neonatale, la madre può sperimentare il contatto con un bambino più vitale e reattivo. Ecco i suoi commenti: “Adesso mio figlio respira da solo, ha due mesi di vita ma io continuo ad avere paura. Questa paura crea uno spazio tra noi, non mi sento libera di esprimermi e avere un contatto intimo con lui. E’ stato lui, mio figlio, con il suo sguardo e le sue smorfie a rassicurarmi, a dirmi che non soffriva, a farmi capire che la paura era solo mia. Ieri, mentre lo tenevo in braccio, mi sono accorta senza ombra di dubbio che mio figlio reagisce ai miei stati d’animo. Alle volte mi nasce una grande rabbia, non accetto che mio figlio sia malato, che rischi la vita e torno a domandarmi il perché di tutto questo. Alle volte invece, mentre sto accanto a lui e mi accorgo che soffre o che è spaventato, mi sento in colpa e responsabile di tutto il dolore che deve sopportare.”
Pochi giorni prima delle dimissioni la madre nel concludere la sua narrazione afferma: “ Ormai non mi chiedo più il perché delle cose, ho scoperto che posso solo accettare la realtà, che non c’è altra risposta. All’inizio non era mio, ora è mio”.
Discussione
Nel modello proposto da Drotar la prima reazione emotiva che i genitori sperimentano a seguito della comunicazione della diagnosi è lo shock, che chiaramente traspare anche nelle parole di questa madre: “ Il terrore mi faceva abbandonare il pensiero e non fui capace di fare nemmeno una domanda delle mille. L’unica cosa che ricordavo al termine del primo colloquio era che mio figlio aveva solo il 60% di sopravvivere”. E’ evidente come, l’ansia attivata dalla diagnosi, venga a configurare uno stato psichico in cui l’acquisizione delle informazioni è inevitabilmente ridotta.
Lo stato di shock della madre traspare chiaramente durante il primo colloquio con l’équipe anche dal comportamento non verbale. “Il suo sguardo durante il colloquio solo a tratti si posa sul chirurgo e sulla psicologa, ascolta, annuisce ma non fa domande. Osserva silenziosa il disegno che il medico fa della malformazione e appena termina il colloquio, esce velocemente dalla stanza come volesse scappar via, non solo dalla stanza ma anche dagli operatori, dalle loro parole e quindi dalla realtà con cui è dovuta entrare a contatto, suo malgrado”.
Come ha evidenziato anche Drotar nella sua ricerca, già al termine del primo colloquio compare la negazione, ossia il primo estremo tentativo di allontanare e negare la realtà della malformazione: “Per tutta la gravidanza fino al parto mi dicevo che non era vero, che si erano sbagliati”.
Inizialmente la madre nega la gravità della situazione e sembra affidarsi al pensiero magico che tutto possa improvvisamente risolversi. Anche in seguito, durante la gravidanza, usa il diniego della realtà ogni qualvolta emerge in lei prepotente il pensiero che suo figlio possa morire: “ Mi ripetevo che alla nascita mi avrebbero detto che stava bene”. Ma naturalmente, al di là del diniego, l’emozione più intensa e profonda che accompagna questa madre per tutta la gravidanza è la paura della perdita del figlio.
Ed è proprio questa paura della morte che, come riportato da Drotar, rende in genere le madri riluttanti a stabilire un legame affettivo con il proprio figlio.
Questa madre evita consapevolmente l’unione fusionale con il feto: le fantasie sul figlio sono limitate e attende con ansia e paura che il periodo della gestazione si concluda il più rapidamente possibile. Non solo il bambino immaginato e atteso fino al momento della diagnosi scompare ma diventa estremamente difficile pensare e fantasticare un bambino “malato” che nasce e che poi forse muore.
La creazione di uno “spazio potenziale”, inteso come area intermedia tra fantasia e realtà, in cui la madre può provare a sviluppare la relazione con il figlio, è messa a rischio dal dato di realtà schiacciante della diagnosi.
Anche la rabbia e il senso di colpa, descritti da Drotar nel suo campione, sono presenti e vengono riportati dalla madre come particolarmente intensi subito dopo la diagnosi e ogniqualvolta torna a chiedersi il perché di questa esperienza: “Ero arrabbiata. Perché Dio mi metteva di fronte a un’esperienza del genere?”.
In gravidanza vi è un alternarsi continuo di emozioni e stati d’animo diversi e l’unica forma di difesa elaborata da questa madre è il “fare finta”, il comportarsi come se non fosse vero per non essere sopraffatta dall’angoscia, dalla delusione e dalla rabbia.
Non osserviamo nella fase prenatale l’adattamento alla realtà descritto da Drotar, inteso come un venire a patti, un prendere contatto con la realtà di un figlio malato e in pericolo e con se stessa, come genitore di un bambino portatore di un problema.
Dopo la nascita
Questa madre immediatamente dopo il parto rivive le emozioni già sperimentate in gravidanza, rivelando una continuità nel modo di rapportarsi al figlio tra la fase prenatale e quella post-natale. Al momento del primo incontro con il figlio, a cinque giorni dal parto, ricompare infatti la negazione come meccanismo difensivo di distanziamento tra sé e il bambino: “Quando mi avvicinai a lui, il mio primo pensiero fu: questo non è mio figlio. Avevo solo voglia di scappare.”
Dopo l’operazione chirurgica anche la paura riemerge in primo piano. Di fronte all’incubatrice del figlio intubato e sedato la madre riferisce questi vissuti: “La paura era costante e l’interrogativo sempre presente che mi occupava la testa, era: vivrà?, respirerà mai da solo?”
Nei primi giorni, come emerge dalle osservazioni della psicologa: “la paura della madre appare chiaramente nei suoi occhi spalancati, nel suo guardare a distanza il figlio senza osare toccarlo, se non per qualche secondo con la punta delle dita. Lo sguardo non può sostare a lungo sul figlio ma si sposta in continuazione dal bambino ai monitors che lo circondano. C’è un profondo silenzio tra loro due, le parole non possono essere ancora usate dalla madre per entrare in contatto con il figlio: “quando stavo accanto all’incubatrice, mi dicevo: che ci faccio io qui?”.
Questo distanziamento affettivo, in parte collegabile al mancato riconoscimento del bambino che ha di fronte come proprio figlio, è presente anche nella narrazione della madre: “Andavo da lui ogni giorno ma non lo sentivo ancora mio, c’era ancora distanza tra noi”.
Questa difficoltà iniziale di riconoscimento del proprio figlio intubato, inerte, incapace di qualsiasi risposta, la si osserva frequentemente ed è in genere vissuta e riportata nelle storie narrate dalle madri, come particolarmente dolorosa e perturbante. In particolare questa madre appare molto spaventata dalla sua reazione e si domanda se è pazza, visto che non riesce a riconoscere il proprio figlio: “ Mi dicevo: forse sono diventata pazza, come è possibile che non lo sento ancora mio, è una cosa così innaturale!”
Solo successivamente, con l’avviarsi della relazione con il bambino, compaiono l’adattamento e la riorganizzazione. Questo dato corrisponde a quanto descritto da Drotar, che sottolinea come la possibilità di prendersi cura del bambino riduca l’ansia e la rabbia e promuova un iniziale adattamento alla realtà.
Infatti solo dopo due settimane passate in terapia intensiva, quando il bambino, sebbene ancora intubato, comincia ad accennare qualche movimento e riesce ad aprire gli occhi per più di qualche istante, inizia gradualmente a esserci un contatto reale, più ravvicinato e intimo. La madre può finalmente riconoscerlo come suo e come realmente esistente perché si sente riconosciuta dal figlio che la guarda e le stringe il dito
A partire da questo momento si osserva nella madre un graduale processo di riconoscimento e accettazione del figlio malato, anche se l’acquisizione che il bambino può guarire e che la morte e il dolore non sono più compagni di strada, avviene lentamente.
Sono presenti anche la rabbia e il senso di colpa già sperimentati in gravidanza: “Alle volte mi nasce una gran rabbia, non accetto che mio figlio sia malato, che rischi la vita e torno a domandarmi il perché di tutto questo. Alle volte invece, mentre sto accanto a lui e mi accorgo che soffre o che è spaventato, mi sento in colpa, responsabile di tutto il dolore che deve sopportare.”
Anche la paura permane sullo sfondo ma piano piano la relazione si stabilisce sempre più intensa e comincia a esserci lo spazio per un dialogo e un ascolto reciproco.
Solo al termine della degenza comincia a rivelarsi in questa madre la possibilità di accettare la realtà: “Non mi chiedo più il perché, ho scoperto che posso solo accettare la realtà, che non c’è altra risposta”.
Conclusioni
La comunicazione della diagnosi in gravidanza si mostra come un doloroso momento di disequilibrio psichico per la madre: allo shock iniziale seguono la negazione, il diniego, la rabbia e il senso di colpa, tutti tinti dall’affetto dominante della paura. La capacità di questa madre di stare in rapporto con il figlio, di pensarlo e immaginarlo appare in parte compromessa. Soltanto il contatto diretto con il bambino apre uno spazio mentale, affettivo e fisico di riconoscimento e di relazione con il bambino, che la madre ha espresso sinteticamente con queste parole: “Non era mio, ora è mio”. E’ inoltre significativo sottolineare che nelle prime settimane di vita, quando il rischio di morte del bambino era ancora elevato e la sedazione impediva ogni possibilità di reciprocità, si sono riproposte nella madre le medesime emozioni sperimentate in gravidanza.
A differenza di quanto riportato da Drotar, la narrazione di questa madre indica che, quando la diagnosi di anomalia congenita viene posta in gravidanza, il processo di adattamento materno può non giungere alla fase di adattamento e riorganizzazione prima della nascita del figlio. E’ solo il contatto con il bambino sempre più vitale e reattivo a stimolare l’attaccamento materno così come ad attivare una possibilità di adattamento alla realtà.